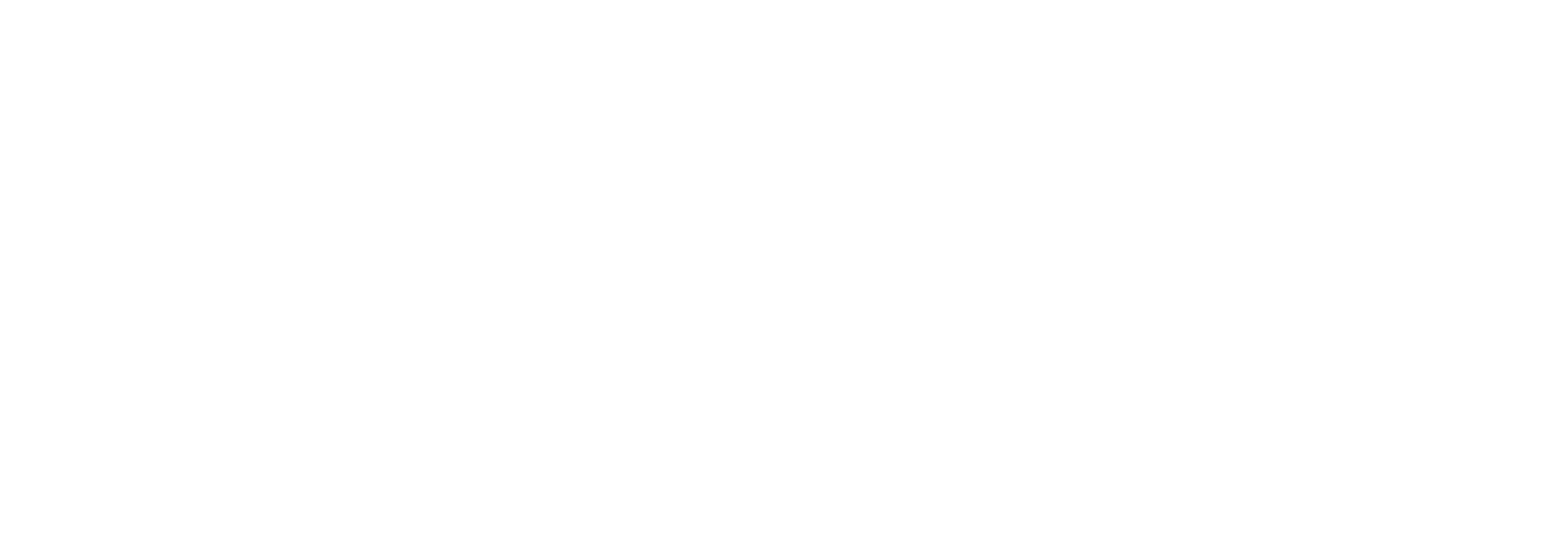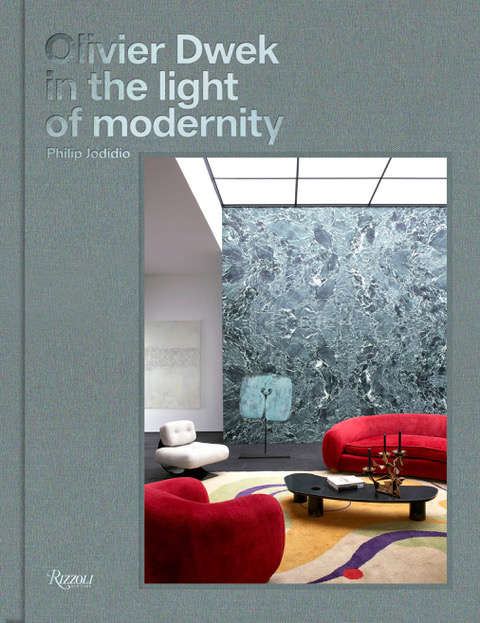Sincretismo estetico: è questa la cifra di Olivier Dwek, architetto belga che si muove in bilico fra arte, architettura, decorazione e interior design. Oggi celebrato dalla prima monografia dedicata alla sua opera, scritta dal critico americano Philip Jodidio e pubblicata da Rizzoli New York
Architettura, interior design, decorazione. Da quando ha avviato la sua carriera internazionale con l’apertura del suo studio omonimo a Bruxelles, Olivier Dwek si è sempre mosso in bilico tra queste discipline, per lui interconnesse e inseparabili. Era il 2000, il primo progetto fu per una boutique Louis Vuitton in un edificio storico della capitale belga. Da allora l’architetto oggi 51enne non si è mai fermato, ha conquistato notorietà e premi, e adesso, a venti anni di distanza da quell’inaugurazione, è il momento di un nuovo traguardo: a maggio 2021 è uscita “Olivier Dwek: In the Light of Modernity”, prima monografia dedicata alla sua opera, scritta dal critico americano Philip Jodidio e pubblicata da Rizzoli New York.
Ricco di scatti fotografici, il volume offre uno sguardo puntuale su alcuni dei progetti più sorprendenti di Dwek, dal restauro di una residenza in stile Art Nouveau nella sua Bruxelles a un elegante appartamento nel sobborgo parigino di Neuilly-sur-Seine, fino a un paio di residenze in cemento bianco e pareti di vetro arroccate sulle scogliere dell’isola greca di Zante. Perché non c’è un ambito specifico in cui il nostro si è specializzato.
Il curriculum di Dwek comprende negozi e spazi espositivi, loft, ville e manieri come vecchie fabbriche rinnovate, e rispecchia la sua volontà di intrecciare più registri per dare vita a un sincretismo estetico incentrato sul dialogo tra periodi storici, sulla sovrapposizione di livelli di significato, sulla ricerca di texture originali e nuovi materiali, oltre che su un sapiente uso della luce naturale.
Il titolo del libro, “In the Light of Modernity”, rimanda a quest’ultimo elemento, fondamentale, secondo Dwek, per creare continuità visiva tra interno ed esterno e regalare vitalità all’architettura. Ottimo esempio, da questo punto di vista, è la G House, residenza d’inizio XX secolo a Bruxelles, ristrutturata da Dwek puntando su bianchi candidi e nuance tenui e su un pavimento in legno chiaro naturale proprio al fine di valorizzare la luminosità degli ambienti. Ma non è da meno la DS House, sempre a Bruxelles, espressione dell’amore dell’architetto belga per le simmetrie imperfette: la facciata riflette la tensione tra la maestosità dell’equilibrio assoluto e una dinamicità ottenuta con cavità e sporgenze inaspettate disegnate ad hoc.
La conciliazione di epoche e stili, si diceva, è un altro obiettivo importante per l’architetto raccontato da Jodidio, obiettivo perseguito con la consapevolezza che nel momento in cui si decide di fondere tradizione e modernità è essenziale che le due non si annullino a vicenda e che, semmai, risplendano nell’interazione con le rispettive peculiarità. Quanto al rapporto tra dentro e fuori, si pensi alla Silver House a Zacinto, progettata in modo da enfatizzare il panorama, con le finestre a incorniciare i paesaggi nell’ottica di una concezione quasi teatrale degli spazi, vedi l’illusione d’infinito prodotta dalla piscina a sfioro sul mare.
Ma c’è qualcos’altro che rende affascinante il lavoro di Dwek ed è la sua passione per l’arte applicata all’architettura e unita a una ricerca rigorosa di purezza formale. Il risultato sono ambientazioni dall’aura museale che, in un contesto di lusso confortevole e sofisticato, inseriscono di volta in volta non solo pezzi di design da collezione – e qui le firme vanno da Jean Prouvé a Charlotte Perriand ad Alvar Aalto, da Pierre Paulin a India Mahdavi -, ma anche opere di pittori e scultori contemporanei, da Robert Motherwell a Ed Ruscha, da Jean-Michel Basquiat a Richard Serra, da Bruce Nauman a Wolfgang Tillmans.
Merito di un percorso formativo eclettico che ha visto Dwek, classe 1970, studiare all’Accademia di Belle Arti prima di accedere alla Facoltà di Architettura Victor Horta a Bruxelles. Ora lo attendono nuovi progetti in giro per l’Europa e una collaborazione con la Calder Foundation di New York. Nel segno di quelli che definisce i suoi maestri: Ludwig Mies van der Rohe, Richard Meier e John Pawson.