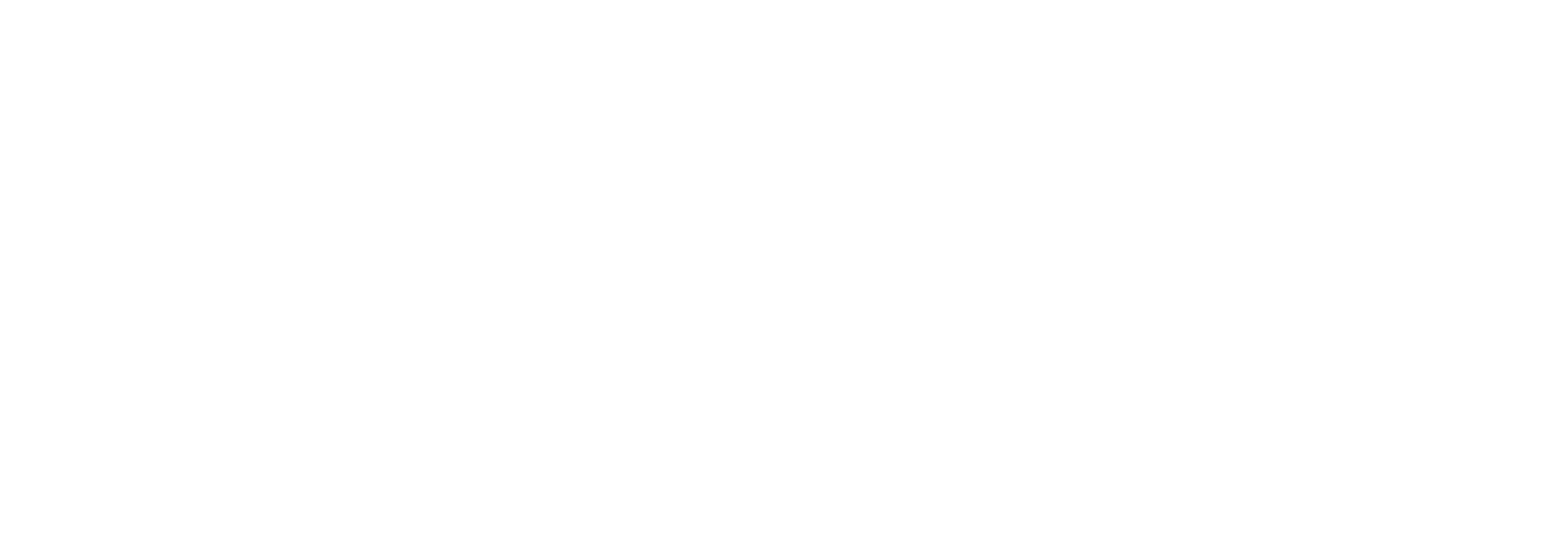Non solo forma e funzione, ma anche narrazione. Rispettosa della cultura e dei luoghi, ma in dialogo con il mondo. Dai grandi masterplan al progetto d’interni, le architetture di MARCO PIVA disegnano un vivace viaggio intellettuale all’insegna della trasversalità
Emozionante, fluido, funzionale. Sono queste le parole con cui Marco Piva definisce il suo approccio progettuale, maturato in anni estremamente trasformativi dal punto di vista culturale, declinato in creazioni che hanno esplorato tutte le scale del progetto, dall’architettura al product e interior design fino ai masterplan. E che dal 1984, anno di apertura del suo atelier milanese, ha dato vita a numerosi progetti nell’ambito dell’ospitalità. Dalla nostra conversazione emerge una straordinaria curiosità culturale, un tratto che ispira e anima il suo intero percorso progettuale.
La trasversalità è una delle cifre distintive del suo lavoro: da dove nasce questa vocazione?
Innanzitutto dalla mia formazione accademica. Ho frequentato il Politecnico di Milano in un’epoca in cui al futuro progettista veniva insegnato a misurarsi con le diverse scale del progetto – “dal cucchiaio alla città”, per dirla con Ernesto Nathan Rogers -, un approccio sempre di estrema attualità e che fra l’altro permette di ottenere esiti di grande coerenza. Coniugare architettura, interior e product design è un’impronta culturale – e un piacere – che ha caratterizzato tutto il mio lavoro, e che mi ha permesso di estendere questo approccio al progetto anche alla scala urbana, soprattutto all’estero, con lo sviluppo di diversi master plan sia in Cina che in Medio Oriente.

L’internazionalità è un’altra delle sue peculiarità: cosa comporta in termini di approccio al progetto rispetto alla realtà italiana?
Esistono sicuramente alcune differenze, anche se soprattutto in questi ultimi anni il mondo della progettazione ha avuto una forte evoluzione anche nel nostro paese. Nello sviluppo di un progetto sono oggi coinvolte figure e discipline che non esistevano al tempo della mia formazione. Penso a project management, procurement, e più in generale a ruoli e funzioni che appartengono a una tradizione progettuale di matrice anglosassone, in cui ogni step del progetto ha un suo referente e ognuno opera in coordinamento con gli altri. In questo senso la capacità di misurarci con tutti i temi e le scale del progetto ha indubbiamente facilitato la relazione con questo modello, senza dubbio più sistematizzato ed efficiente dal punto di vista del controllo dei processi, cui abbiamo unito tutta la ricchezza della straordinaria tradizione italiana nell’ambito dell’architettura e del design.

La centralità del genius loci, e più in generale la capacità di creare una narrazione intorno al progetto, connota in misura importante i suoi lavori, non solo in Italia ma anche all’estero…
Ogni realtà offre spunti e si presta in misura diversa a questo tipo di lettura, ma il nostro compito di progettisti è proprio quello di trovare sempre una motivazione emozionale, poetica, narrativa capace di dare un imprinting al progetto, rendendolo riconoscibile e portatore dei valori e dell’ethos dei luoghi. In questo senso non c’è dubbio che la possibilità di coniugare progettazione architettonica e interior design sia idealmente il modo migliore per rendere gli esiti di questa lettura organici e completi.

Cosa significa adottare questo approccio in contesti culturali e territoriali molto diversi tra loro?
Significa innanzitutto avere un approccio aperto alla loro lettura e comprensione. Che spesso riserva delle sorprese. Anche realtà molto lontane dalla nostra ma con una tradizione culturale altrettanto forte – penso in particolare alla Cina – hanno una sensibilità estetica che, anche se non sul piano formale, è in realtà molto vicina alla nostra su quello concettuale, oltre a una grande consapevolezza del legame fra architettura e territorio. Non è un caso che proprio in Cina il nostro studio abbia curato diversi importanti masterplan, in cui non solo questa visione unitaria è protagonista, ma rappresenta anche un trait d’union fra le nostre culture. Uno dei migliori esempi in questo senso è il master plan che abbiamo sviluppato per l’area del lago di Dianshan, il cui concetto ispiratore è proprio il legame fra la cultura occidentale e quella orientale, declinato in un continuum che ne riprende una serie di segni ed elementi condivisi.
In altre realtà, come gli Stati Uniti, in alcuni casi è soprattutto il territorio a fornire spunti per la costruzione di una narrazione, e quindi è il dialogo fra architettura e paesaggio, fra interno ed esterno, a essere elemento centrale del progetto. Contesti fortemente urbanizzati – penso a New York, dove oggi abbiamo una presenza diretta – presentano invece caratteristiche di leggibilità e vivibilità degli spazi molto simili a quelle di una città come Milano, e sono al centro di una serie di progetti che stiamo sviluppando in ambito residenziale e hospitality.

Proprio a questo riguardo, com’è cambiata la progettazione dello spazio hotel in questi ultimi anni?
È cambiato praticamente tutto. Ci siamo dedicati a questo ambito proprio nel momento in cui questo tema progettuale ha vissuto una rivoluzione, che se dal punto di vista tipologico ha dato vita a nuovi format su un piano più generale ha avviato una grande trasformazione nella stessa interpretazione degli spazi dell’ospitalità, cui abbiamo dato il nostro contributo con numerose esperienze e sperimentazioni. Esperienze che hanno avuto come elemento centrale il superamento di alcuni stereotipi e modelli, spesso di importazione statunitense, e un’interpretazione alternativa dello spazio hotel in stretto dialogo con il tessuto culturale, urbano, artistico, capace quindi di coniugare gli aspetti funzionali con quelli emozionali ed esperienziali. Un’evoluzione cui anche la forza del tessuto produttivo italiano ha dato un contributo importante, fornendo una piattaforma a supporto di queste sperimentazioni.
Come tutto questo ha influenzato il processo progettuale?
I cambiamenti metodologici sono stati importanti. Se prima il nostro interlocutore era spesso il singolo proprietario della struttura, oggi i soggetti coinvolti sono investitori, gestori, brand, controller di qualità, immagine e prestazioni. È un mondo più complesso, senza dubbio, e più il progetto ha una scala importante più queste figure si moltiplicano, rendendo i processi molto più articolati.

Qual è il prossimo passo?
Senza dubbio una crescente presenza della tecnologia, che in hotel sarà estesa ma al tempo stesso discreta e “trasparente”. Il rapporto tra individuo e spazio è sempre più puntuale e interattivo, e la creazione di un habitat capace di interpretarlo comporterà un crescente carico tecnologico che andrà concepito e governato in modo dinamico, vista la rapidità delle sue evoluzioni. Ad esempio meno comandi, ma più efficienti, modulari e riconfigurabili, integrati non solo nella struttura ma negli stessi arredi e oggetti. Che diventano così elementi di una catena tecnologica attiva sempre più performante e con un impatto sempre più importante sulla configurabilità degli spazi, delle loro atmosfere e quindi sull’esperienza dell’ospite.