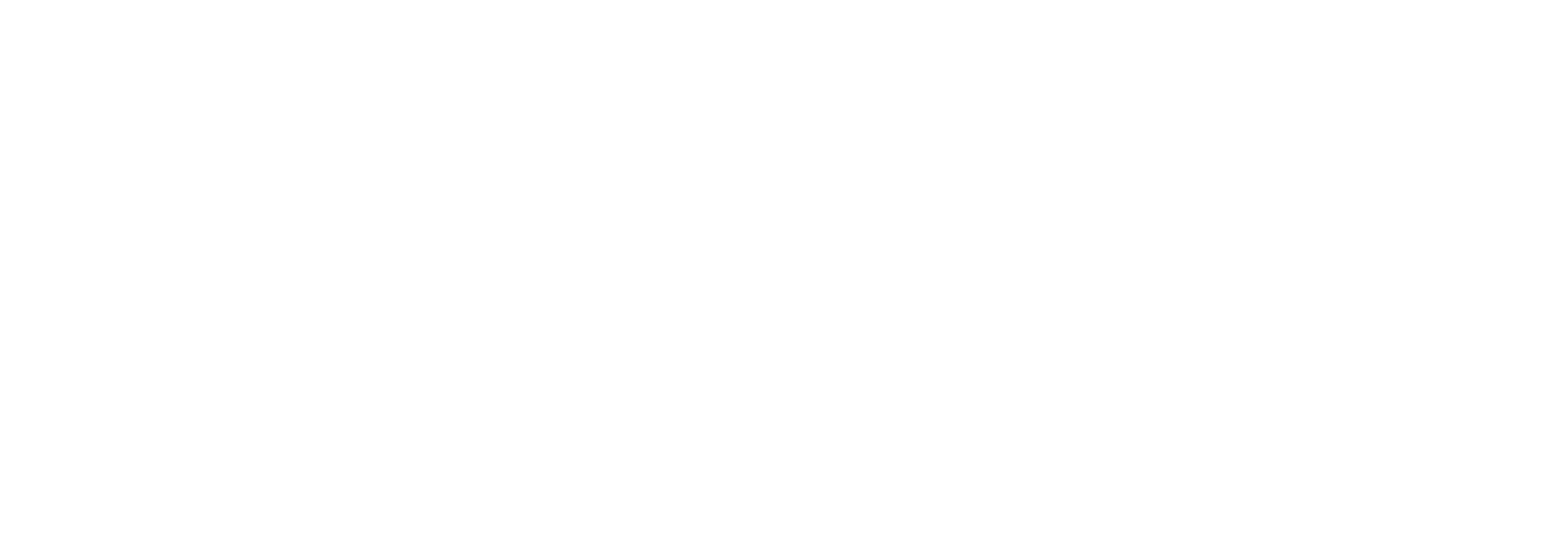Un alveare di valori e materiali in continua interazione: con questa metafora DEGW ha guidato il progetto della nuova sede EY di Roma. Con un innovativo wavespace, nel quale le neuroscienze dialogano con l’architettura
La nuova sede EY di Roma – leader nei servizi di assistenza fiscale e legale – è un progetto firmato DEGW-Lombardini22 che nasce dalla volontà di EY di trasferirsi nel central business district di Roma, nei pressi di Villa Borghese. I nuovi uffici constano di circa 900 postazioni e diverse tipologie di spazi, distribuiti su nove piani fuori terra e tre piani interrati per circa 18.000 metri quadrati di superficie.

Il concept messo a punto da DEGW è rappresentato dall’immagine dell’alveare, declinata in un duplice significato: un livello organizzativo, riferito all’idea di operosità, e un livello di riconoscibilità corporate, come rimando cromatico – nei toni giallo e nero – alla brand identity di EY.

Le stesse geometrie degli spazi interni si rifanno alla metafora formale dell’arnia e dell’alveare: la geometria ben definita, ordinata e cartesiana dell’arnia organizza gli spazi operativi e le aree client ed executive, mentre le forme più libere, biologiche e irregolari dell’alveare configurano la reception, gli spazi break e l’innovation area.

Al piano terra si trovano tre funzioni primarie: la Reception, l’area Recruiting e, passando attraverso un’ampia caffetteria, l’area Training. A ridosso dell’ingresso secondario sono invece collocate le funzioni complementari con i servizi. Tutto ruota intorno al patio interno, rinnovato nella pavimentazione e riconfigurato come un anfiteatro a gradoni in comunicazione con una grande caffetteria interna.

Dal primo al sesto piano si sviluppano le aree di lavoro con alcune posizioni costanti per garantire chiarezza distributiva su tutti i livelli. A ogni livello ricorrono: hub di piano di fronte agli sbarchi ascensori, archivi, meeting room, hub informali delimitati da tende acustiche, chat sofa, just in time, booths.

Due zone speciali sono caratterizzate da scrivanie mobili a coda di rondine e da un grande arredo circolare su misura con postazioni perimetrali. La vicinanza a Villa Borghese è stata poi determinante per valorizzare alcune funzioni più conviviali, in particolare le break area well-being con attrezzi Technogym e con affaccio privilegiato sul parco.

Il settimo piano è diviso tra le aree Client e l’innovativo EY wavespace, che mette a frutto le ricerche e le esperienze maturate nell’ambito di Tuned, iniziativa trasversale di Lombardini22 creata nel 2016 da Davide Ruzzon e oggi compiuto servizio dedicato all’applicazione delle neuroscienze all’architettura.

“Ciò che le neuroscienze stanno mettendo a disposizione degli architetti è una conoscenza predittiva di immensa portata” – afferma Davide Ruzzon, direttore di Tuned e responsabile scientifico del Master NAAD, Neuroscience Applied to Architectural Design presso lo Iuav di Venezia – “ed è difficile ormai non proseguire su questa strada. Capire come i nostri bisogni più profondi cerchino una sintonia, nei luoghi di lavoro, tra attività e forma spaziale, è oggi possibile. È un sapere scientifico, certo, ma che non pretende di occupare il cielo. È piuttosto un sapere umile, di servizio, che oggi ci fa agire con più consapevolezza verso un benessere mentale, fisico e relazionale nel mondo ufficio. Non dimentichiamo che secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il burn out, lo stress, oggi classificato ufficialmente come sindrome, brucia ogni anno un trilione di dollari nel mondo delle aziende”.

Nel Wavespace il concept formale dell’alveare si esprime in un particolare spazio di mediazione – un esagono smussato e irregolare che avvolge il nucleo scale-ascensori con pareti in lamiera stirata – che contiene i servizi e distribuisce i flussi alle diverse aree funzionali: sette stanze, ognuna dedicata ad altrettante attività che costituiscono una sequenza esperienziale evocativa.
Per la sua progettazione la domanda di fondo è stata: come stimolare l’attivazione dello spazio? Ogni attività umana, infatti, innesca attese emotive diverse che l’architettura può “rispecchiare” attraverso l’organizzazione delle sue componenti plastiche, materiche, ritmiche, luminose, cromatiche e acustiche.

Obiettivo è equilibrare le dimensioni pre-riflessive e cognitive e rafforzare così l’attività svolta. Poiché la fruizione dello spazio interno architettonico è sempre un attraversamento corporeo, i movimenti del corpo e i suoi diversi cinematismi sono adottati come riferimento concettuale della morfologia dello spazio: le configurazioni degli ambienti accompagnano così i fruitori sollecitando una serie di sentimenti di fondo associati alle finalità dei diversi ambienti. Tradurre questa sorta di “cinematica emotiva” del corpo in spazi dinamici è l’analogia chiave del progetto.