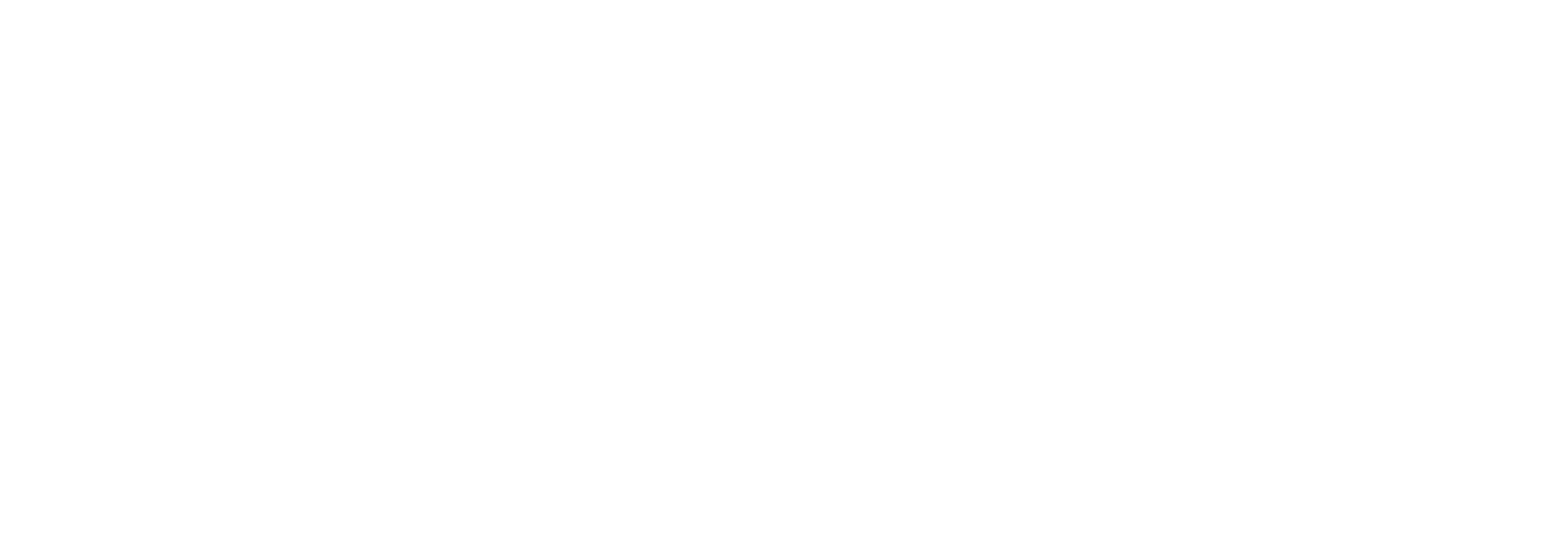È di Studio Münster il progetto della nuova biblioteca nazionale del Lussemburgo. Oggi aperta al pubblico a conclusione di un processo durato ben sedici anni, incominciato nel 2003 con la vittoria del concorso internazionale da parte dello studio fondato da Julia Bolles-Wilson e Peter Wilson
Solo un intervento – ci ricorda Julia Bolles-Wilson – è capace di produrre un luogo, in quanto provoca un nuovo inizio e il mondo viene reinventato. “L’architettura oggi è sia globale che locale e ha una funzione iconica che deve, da un lato, ancorare il suo prodotto a un determinato luogo, dall’altro fornire immagini seducenti per un palato mediatico sempre più assuefatto”.
Sono premesse che ben si addicono al progetto della nuova biblioteca nazionale del Lussemburgo, aperta al pubblico nell’ottobre del 2019 a conclusione di un processo durato ben sedici anni, incominciato nel 2003 con la vittoria del concorso internazionale da parte dello studio Münster fondato da Julia Bolles-Wilson e Peter Wilson.

Inizialmente la biblioteca avrebbe dovuto essere costruita nel Robert Schuman Building del Parlamento Europeo, ma successivamente agli architetti venne richiesto il progetto per un nuovo edificio, avendo a disposizione un investimento di settantacinque milioni di euro.

L’edificio si trova sulla Kennedy Avenue a Kirchberg, un quartiere a nord est del centro, sede di varie istituzioni dell’Unione Europea, della Philarmonie Luxembourg e del Mudam, il museo d’arte moderna. La biblioteca si presenta sul viale con una facciata imponente, che allo stesso tempo invita il visitatore ad entrare, grazie all’articolazione dei volumi e alla grande vetrata in bronzo che conclude la parete di ingresso rivestita con elementi lineari in pietra che ricordano i libri. Il volume è rivestito con pannelli in calcestruzzo molto pesanti – di grande formato e spessi otto centimetri – le cui differenti nuance sono dovute al trattamento superficiale di sabbiatura.

Dall’entrata si incontrano in sequenza gli ambienti principali: oltre al foyer, un centro per conferenze e seminari; ma il cuore della BnL è la sala di lettura a terrazze, che sormonta l’archivio centrale, compatto su cinque livelli, in cima al quale si trovano la grande area con scaffali e la principale piattaforma di lettura. Si ritrova qui, nella compresenza di elementi grandi e piccoli, nella moltiplicazione delle possibili angolazioni e degli sguardi, quel trattamento degli interni come paesaggio che caratterizza gli edifici pubblici dello studio, compresa la rimpianta – in quanto mai realizzata – Biblioteca europea di informazione e cultura di Milano – Beic (2001).

Anche il colore è protagonista: per la sala di lettura dei periodici, completamente rossa, e per il grande tappeto blu intenso delle aree pubbliche.

La biblioteca conserva, raccoglie e cataloga tutte le pubblicazioni edite in Lussemburgo e quelle pubblicate all’estero sul Granducato, compresi alcuni testi la cui perdita – o anche il solo danneggiamento – sarebbe un danno incalcolabile per la comunità. Si pensi che il documento più antico è il frammento di un manoscritto di Gregorio Magno della fine del VII secolo e che la collezione comprende molte edizioni rare di autori francesi, fra cui René Descartes.

Pertanto si sono rivelati strategici nella progettazione i sistemi di sicurezza, antiterrorismo e per la conservazione dei libri, a partire dalla corretta posizione dell’archivio rispetto agli spazi liberi a disposizione del pubblico. Per comprendere l’importanza di questi aspetti, ha raccontato Peter Wilson in una conferenza alla facoltà di Melbourne – sua città natale – che alcuni libri ci mettono due giorni per arrivare dagli archivi alla sala di lettura. Se così non fosse, nel passare dai 18 gradi dell’archivio ai 22 delle sale di lettura subirebbero uno choc irreversibile.
D’altronde la precisione nel risolvere gli aspetti tecnici della costruzione caratterizza l’architettura dello studio, che si è sviluppato in una città tedesca di medie dimensioni, assorbendone la cultura. Un altro aspetto fondamentale è l’attenzione per la durata degli edifici, per la loro presenza concreta e tattile, il loro fare da cornice alla vita di tutti i giorni, il fatto che li impariamo a conoscere lentamente, attraverso la consuetudine dell’uso. Per Bolles+Wilson è ciò che contraddistingue l’architettura dall’immediatezza del digitale e le permette di diventare luogo. Dunque non sorprende che il tema della biblioteca – tempio laico della cultura analogica – sia centrale nella carriera dello studio. In realtà Bolles+Wilson si impongono all’attenzione internazionale proprio grazie al progetto per la nuova biblioteca civica di Münster (1987-1993), a cui seguirà il progetto per la Beic a Milano.

La passione per il tema è tale da aver coinvolto Bolles+Wilson nella progettazione di una piccola biblioteca per il carcere di Münster, che ha avuto un effetto importante sulla vita dei detenuti, dal momento che la lettura è diventata attività prevalente, soppiantando la visione dei programmi televisivi. Alla prima biblioteca è seguita la realizzazione di altre dieci nelle carceri tedesche.
Le scelte tecnologiche per la Bibliothèque nationale, sono state adottate in seguito alla richiesta dell’Amministration des Bâtiments Public di sviluppare un approccio non convenzionale rispetto

ai temi energetici. Scartati i rivestimenti a cappotto, lo studio ha optato per un sistema basato sulla massa termica dell’edificio – a cui contribuisce il pesante rivestimento di facciata – e su alcuni accorgimenti passivi. Ad esempio il tetto in legno lamellare è dotato di griglie all’intradosso, che fanno circolare l’aria al suo interno e lo rendono termicamente attivo, mentre un sistema notturno di apertura dei serramenti raffresca l’edificio, grazie all’aria che per effetto camino fuoriesce dai lucernari triangolari. Questi – orientati a nord – sono fra gli elementi caratteristici della biblioteca, già presenti negli schizzi di Peter Wilson, come il pavimento blu intenso da cui emergono gli scaffali e la scala volumetrica a spirale che connette il foyer con la sala conferenze.
Completa il progetto il sistema segnaletico e orientativo modulare disegnato da Pentagram, basato su 25.000 cubi di resina numerici e alfabetici, 6.000 tableau e 2.400 caratteri numerici per le scaffalature: un sistema flessibile che si può facilmente modificare nel tempo, adattandosi all’evoluzione della biblioteca.