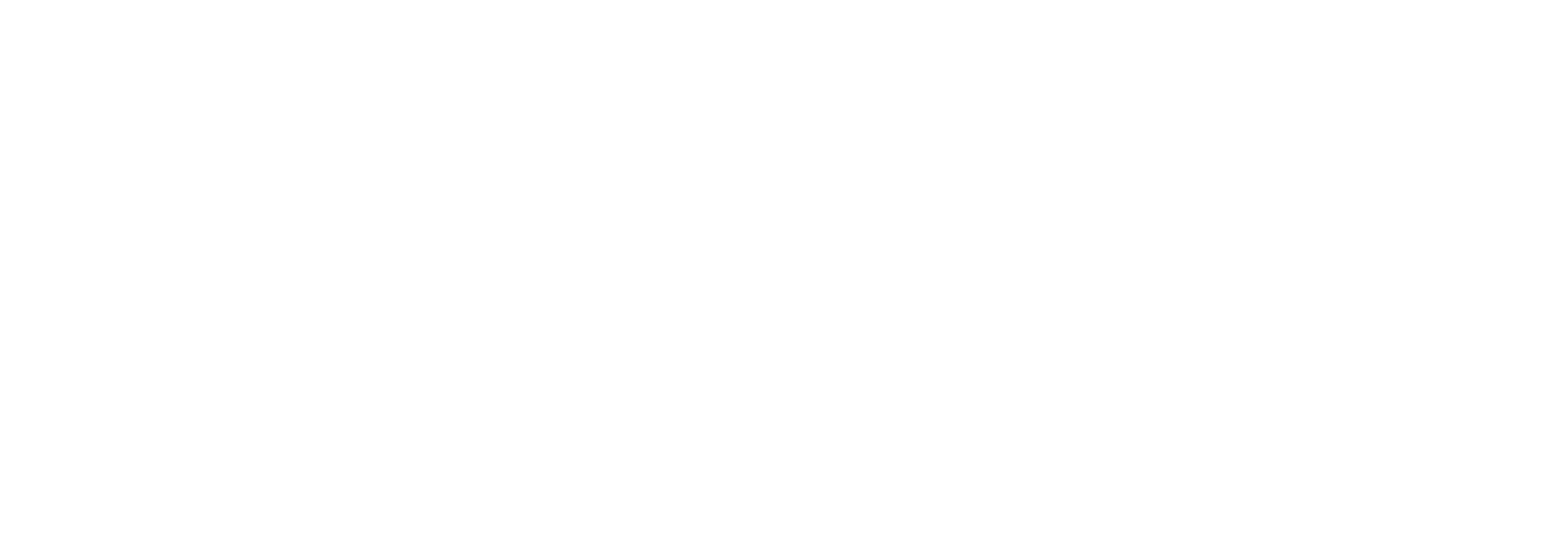Il legame fra l’uomo e la natura è qualcosa di atavico e inscritto nella nostra memoria genetica. Ma ha anche le sue regole. Che possono essere usate per creare ambienti di vita e di lavoro capaci di stimolare il benessere fisico, psicologico ed emotivo
“Green” è una delle parole d’ordine che in questi anni di grande trasformazione degli ambienti in cui l’uomo vive e lavora hanno guidato sia la progettazione architettonica che quella d’interni. Ma i suoi contenuti e significati sono profondamente cambiati. O meglio, si sono ampliati.

Dai risvolti più tecnici, legati ad esempio alle performance energetiche degli edifici o all’adozione di metodologie costruttive volte a ridurre la loro impronta ambientale, la ricerca ha via via abbracciato il campo assai più complesso delle neuroscienze per indagare le relazioni profonde che legano l’uomo e l’ambiente costruito.
Scoprendo una profonda connessione fra il suo benessere psicologico ed emotivo e la quantità e il numero di elementi che negli spazi di vita e di lavoro si richiamano alla natura. Nasce così il nature based design o progettazione biofilica, concetto che se in ambito teorico data già qualche anno, solo in tempi recenti ha iniziato a trovare applicazione sia negli ambienti abitativi che in quelli dedicati al lavoro, allo svago e al relax. Il suo obiettivo? Introdurre nei nostri spazi quotidiani non solo più elementi naturali, ma le stesse forme della natura per farci vivere meglio.

Dalla teoria alla pratica
Di progettazione biofilica si parla ormai da diversi anni, più precisamente da quando il biologo statunitense Edward Wilson dà la prima definizione di biofilia come tendenza innata a concentrare la nostra attenzione sulle forme di vita e tutto ciò che le ricorda e, in determinate circostanze, a creare con loro un legame emotivo. Corollario di questa definizione è il fatto che benessere fisico ed emotivo e qualità della vita sono direttamente legati al grado di connessione che riusciamo a mantenere con gli elementi naturali anche quando viviamo in spazi artificiali come quelli costruiti.
La biofilia infatti è innata, ma non è istintiva. E va stimolata, se vogliamo beneficiare dei suoi effetti sulle nostre funzioni cognitive ed emozionali. Da qui all’ingresso della biofilia nell’ambito dell’architettura e dell’interior design il passo è stato relativamente breve. A compierlo per primo è il sociologo Stephen Kellert che a metà degli anni Novanta dà vita alla corrente del Biophilic Design, formalizzando per la prima volta i concetti ispiratori della biofilia in caratteristiche ed elementi concreti capaci di ricreare in ogni ambiente costruito una connessione con la natura. Quali? Utilizzare materiali e superfici naturali, sfruttare l’illuminazione solare e, soprattutto, inserendo del verde nell’edificio.

Ma attenzione: questi inserimenti spesso rischiano di essere solo una rappresentazione artificiale e astratta della natura, privi della complessità che la caratterizza. Non basta insomma, qualche pianta in vaso o un angolo di prato. Un passo in più è la creazione di veri e propri ecosistemi in miniatura all’interno degli spazi costruiti, che hanno anche il vantaggio di creare un migliore microclima interno e contribuire alla sostenibilità complessiva dell’edificio. Ma per attingere alla complessità del legame teorizzato dalle neuroscienze fra uomo e natura, e soprattutto ai suoi benefici effetti, anche questo non è abbastanza.

Il secondo e più profondo aspetto della progettazione biofilica comporta infatti l’implementazione delle qualità geometriche essenziali della natura nell’edificio (oltre che nel contesto di inserimento), che tende così a seguire la stessa complessità delle forme naturali stimolando la percezione e attivando le nostre risposte neurali. Come?

Il progetto biofilico
A oggi il percorso concettuale della progettazione biofilica si traduce in due differenti approcci. Il primo, più facilmente implementabile all’interno dei normali processi progettuali e costruttivi, rimane nel solco dell’edilizia industrializzata inserendovi piante e strutture che riproducono quelle naturali, mentre il secondo tende a modificare materiali, superfici e geometrie dell’edificio per stimolare maggiormente la connessione emotiva con gli occupanti. Pur diversi, entrambi riconoscono l’importanza di un ben definito gruppo di qualità funzionali al loro obiettivo comune, che negli ultimi anni sono stati formalizzati in veri e propri protocolli progettuali.

Una parte di questi fa riferimento alle caratteristiche dell’ambiente, quindi illuminazione naturale, vista verso aree verdi, qualità dell’aria, presenza e densità di piante, materiali di origine naturale per arredi e finiture, tonalità cromatiche e pattern irregolari ispirati a quelli presenti in natura. Ad esempio, motivi decorativi ed elementi architettonici e di arredo che ripetono forme simili in scale diverse come avviene in natura, e vengono quindi percepiti allo stesso tempo come stimolanti e riposanti.

Ci sono poi i già citati parametri geometrici, che si traducono nella riproduzione di forme e modelli del mondo della natura e privilegiano forme e superfici curve e arrotondate in sostituzione delle tipiche geometrie squadrate dell’edilizia ordinaria, e più in generale l’adozione di schemi distributivi aperti capaci di riprodurre la visuale prospettica e a lungo raggio tipica dell’ambiente naturale, intercalati ad aree più intime e raccolte che offrono riparo e rifugio. E, per finire, una serie di elementi legati alle percezioni sensoriali, come ad esempio il mutare dei materiali con il passare del tempo o le relazioni con i luoghi e le loro caratteristiche ambientali e culturali.
E non è tutto. Uno dei risultati più interessanti delle ricerche nel campo della progettazione biofilica è che seguirne i principi fa bene non solo agli esseri umani ma anche al portafoglio, una scoperta che ne ha stimolato l’applicazione non solo negli spazi abitativi ma anche, e soprattutto, in quelli destinati al lavoro, al tempo libero e alla cura di sè.

Al di là dei vantaggi in termini di migliore rendimento energetico, infatti, secondo le neuroscienze inserire elementi naturali nell’ambiente costruito è un buon investimento economico in salute e produttività perché migliora le motivazioni, le capacità cognitive e di apprendimento degli individui, ne stimola il benessere psicologico ed emotivo, accelera i processi di guarigione. Progettare green insomma, fa bene all’ambiente e alle persone. Sotto ogni aspetto.