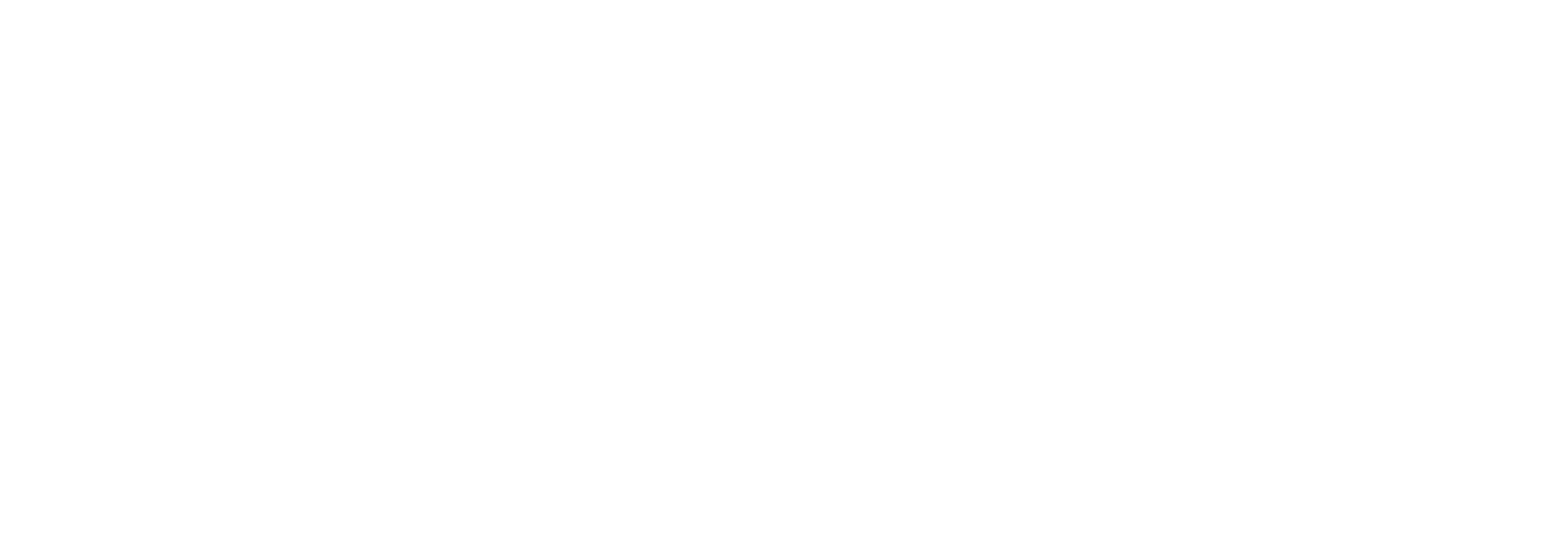“Sono stato attratto dai colori brillanti fin dall’infanzia”: comincia così la nostra intervista ad ADAM NATHANIEL FURMAN. Artista e designer eclettico, nonchè direttore di SATURATED SPACES, gruppo di ricerca dell’Architectural Association di Londra che indaga il ruolo del colore nel design, nell’architettura e nell’urbanistica
Sculture e installazioni urbane, oggetti e complementi d’arredo, decorazione d’interni e collezioni per gallerie d’arte: ad Adam Nathaniel Furman piace spaziare tra tutti questi mondi. Ma se il suo stile è eclettico, c’è un ingrediente che accomuna tutti i suoi lavori: l’uso sfacciato del colore.

Sfacciato, sì, perché il designer e artista londinese, classe 1982, non è certo uno che si risparmia: caratterizzati da tinte vivaci, accese e pastello mescolate in un trionfo cromatico di forte impatto, i suoi progetti si ispirano al suo background multietnico – il padre è argentino, la madre per metà giapponese e per metà israeliana -, e all’ambiente queer in cui è cresciuto.

Un inno alla libertà che è anche un messaggio politico espresso con il linguaggio del design e che gli è valso diversi premi, mostre e l’occasione di tenere lezioni e seminari presso realtà prestigiose come la Harvard Graduate School of Design e il Carnegie Museum of Art di Pittsburgh. “Sono stato attratto dai colori brillanti sin dall’infanzia”, dice Furman.

Da dove nasce questa fascinazione?
Da vari fattori. Da un lato è una questione di gusti, dall’altro ho subìto l’influenza delle personalità vivaci, audaci, sia di mia madre, sia di mia nonna, che ha sempre portato abiti super colorati e scintillanti. Poi c’è stata la scena gay e dei club degli anni Novanta con le sue grafiche sfavillanti. È finita che all’università mi avvicinavo a ogni progetto giocando con i colori, peccato che lì mi abbiano fatto capire che non potevo, che era una cosa da matti.

Cos’è per te il colore nel design, un simbolo?
Esattamente. Dal 2011 dirigo Saturated Space, gruppo di ricerca all’interno dell’Architectural Association di Londra che si occupa del ruolo del colore come protagonista attivo nel design, nell’architettura e nell’urbanistica. Non c’è nient’altro che abbia un impatto visivo sulle persone in maniera così istantanea ed emozionale. Non è un caso che i colori siano importanti per i movimenti di protesta, nei loghi, nelle bandiere: perché sono potenti, perfetti per diffondere valori in modo immediato.

Il tuo stile è anche una risposta al minimalismo che domina da tempo il mondo dell’interior design?
Non sono contrario al minimalismo, ma se fino all’inizio degli anni Novanta è stato uno stile di nicchia, chic, sofisticato, per certi ambienti di Parigi, Tokyo, New York e Londra, in seguito è diventato un’ortodossia: tutto ciò che se ne allontana è additato come strano o frutto di una moda passeggera. Quest’idea che esista una normalità e che ciò che se ne distanzia sia eccentrico o superficiale è soffocante. Adoro il minimalismo di John Pawson, ma non può essere quella l’unica via.

C’è anche un intento, da parte tua, di reinterpretare la storia dell’architettura con un’estetica che fonde più tradizioni culturali?
Amo la storia dell’architettura, studiarla serve a comprendere il contesto in cui viviamo. Ciò detto, nei miei progetti uso i riferimenti storici con un approccio estremamente libero, miscelandoli e intrecciandoli con suggestioni derivanti da storie parallele a quelle che solitamente si studiano, come quella dell’architettura gay o della “failed architecture”.

Nelle tue decorazioni si notano spesso linee circolari che evocano i mandala.
Anche qui vado nella direzione opposta rispetto al minimalismo. In quest’ultimo l’idea è che liberare lo spazio aiuti la mente ad acquietarsi, ma con me non funziona: in un ambiente quasi vuoto vado fuori di testa. Al contrario, contemplare la complessità mi aiuta a liberare la mente, favorisce la meditazione. Non parlo di psichedelia, semmai è come quando passeggi in città e mentre osservi tutto quello che ti circonda ti rassereni. Allo stesso modo, concentrare lo sguardo su un oggetto molto colorato e complesso può essere rilassante.

Qual è il materiale più adatto ai tuoi giochi cromatici?
Sono ossessionato dalla ceramica, materiale che mi affascina perché ha una tradizione antichissima e perché ha trovato e trova tuttora applicazioni diverse in differenti culture. Ho disegnato una linea di piastrelle per Botteganove, e ne ho un’altra in uscita, è uno dei progetti su cui sono impegnato assieme a un’installazione per la National Gallery di Melbourne. Nel Regno Unito il settore della ceramica era rilevante, ma purtroppo è praticamente collassato. Spero di collaborare di più con i marchi italiani, ho notato che preferiscono i vecchi designer, ma manca poco, invecchio pure io (e ride… nda).

C’è un essenziale elemento di queerness nel tuo lavoro, ti preoccupa come i media possono trattarlo?
Non m’interessa, ma di certo la queerness è un elemento clou nel mio lavoro, tant’è che sto scrivendo un libro sul tema. Ciò che mi impensierisce è che la stampa trasformi questo mio approccio in una questione di moda oppure identitaria, come se io fossi solo quello. Invece è importante, ma non è tutto. Le critiche che ho ricevuto per il mio stile sono le medesime che vengono rivolte a ciò che tradizionalmente si considera queer, ma io adoro quello stile, perché dovrei giustificarmi per questo? Perché c’è gente che lo ritiene queer o effeminato? Non sono tenuto a spiegare ciò che faccio in opposizione a ciò che va per la maggiore.