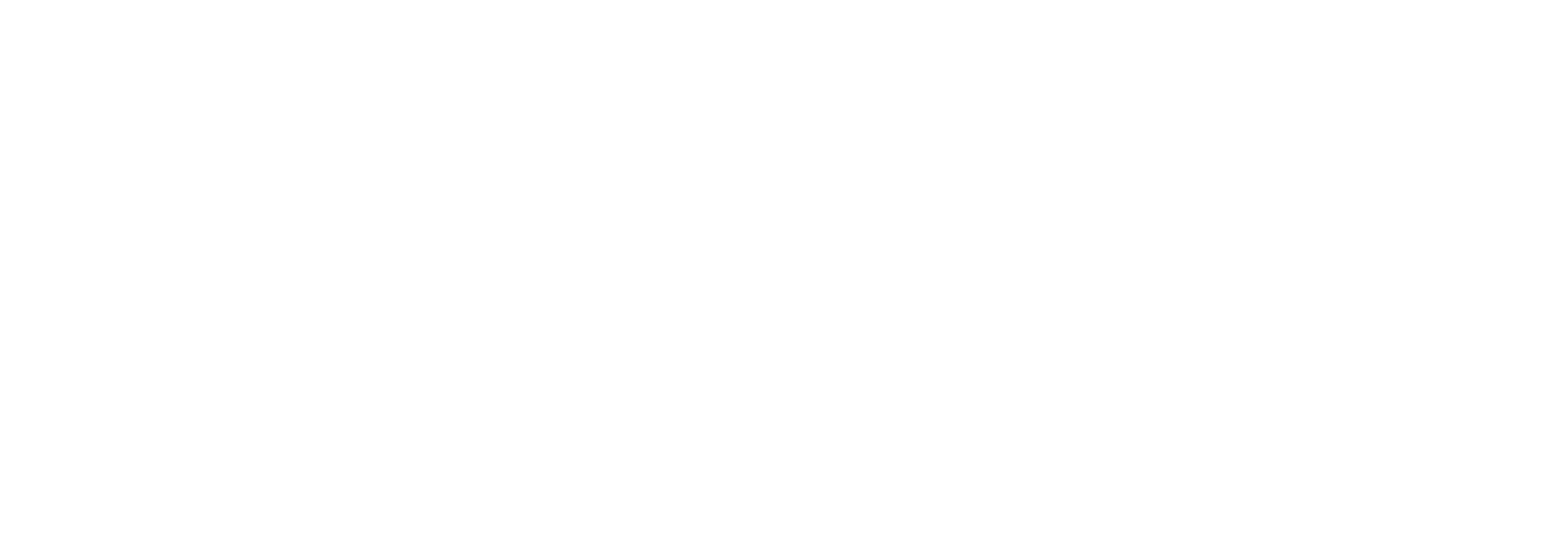Si ispira a un poema classico dell’antica Cina il progetto di 9M DESIGN per il Living Experience Centre a Yiwu. Un’architettura parzialmente interrata che riemerge all’interno del paesaggio naturale e di quello progettato da COLLECTIVE LANDSCAPE DESIGN. Come un’oasi separata dalle fatiche del mondo
La “Primavera della pesca oltre a questo mondo”è un idioma popolare cinese di quattro caratteri che significa un luogo inaspettatamente fantastico al di fuori dai sentieri battuti, tratto dal poema classico di Tao Yuanming “La primavera del fiore di pesco” del 421 d.C., a cui si ispira il progetto per il Living Experience Centre a Yiwu, una città di 1,2 milioni di abitanti vicina a Hangzhou. Il poema narra di un pescatore che risale un fiume in una foresta fatta solo di alberi di pesco in fiore, dove persino il terreno è ricoperto da petali di pesco, fino a raggiungere una grotta. Dopo aver attraversato la grotta, il pescatore raggiunge un villaggio abitato da persone amichevoli e gentili che discendono da antenati fuggiti durante i disordini civili della dinastia Qin, per isolarsi dal mondo circostante. Il pescatore riparte per tornare a casa, cercando in tutti i modi di memorizzare la strada, ma non sarà più capace di ritornarci, né di raccontare a qualcuno la via.

È quindi il tema dell’oasi di pace separata dalle fatiche del mondo che ispira il progetto di questo padiglione, nato come info center di un intervento residenziale in costruzione, e destinato a diventare l’elemento di ingresso di un nuovo parco pubblico. In architettura i progetti che traducono nello spazio i capolavori della letteratura sono rari: in Italia ricordiamo il Danteum di Giuseppe Terragni e Pietro Lingeri con la sua selva delle cento colonne che rappresenta la selva oscura dantesca, dove , ancora una volta, la dimensione esperienziale, emotiva, è preponderante rispetto alla destinazione funzionale, che viceversa si fa sfumata.

Il Living Experience Centre di Yiwu è al centro di un’espansione del villaggio di Zongtang verso le pendici della collina, il cui masterplan e progetto di paesaggio è stato curato da Collective Landscape Design, che ha deciso di conservare fra le due aree residenziali un brano della foresta e una parte di uno stagno esistente.

“Quando l’uomo espande il suo habitat”, spiega Collective Landscape Design, “le strutture ecologiche naturali sono inevitabilmente disturbate e a volte difficili da riprodurre. Se, per mantenere le caratteristiche del sito, si fa semplicemente affidamento su misure di copertura del suolo e modifiche artificiali che necessitano di manutenzione continua, a lungo termine il degrado tenderà a presentarsi”. Di qui la scelta di preservare per quanto possibile intatti gli elementi naturali, quali le macchie di canfora e di paulownia, e di realizzare infrastrutture che interferiscano nella minore misura possibile con il paesaggio: strade in trincea e percorsi pedonali sopraelevati in legno.

Il Living Experience Center si presenta così come uno scrigno nel paesaggio. Il padiglione si trova su un rilievo in prossimità dello stagno, e da un percorso in salita con continui cambi di prospettiva i visitatori attraversano un metaforico bosco di ciliegi e si trovano davanti a muro in terra battuta e a due muri di scisto che, come in un dipinto a inchiostro cinese, definiscono l’ingresso.

Per studiare con precisione le viste sul paesaggio i progettisti del padiglione – 9M DESIGN – hanno costruito un’impalcatura a due piani in scala 1:1, dalla quale controllare le viste. L’edificio è stato così progettato parzialmente interrato rispetto alla quota del terreno. L’effetto di riemersione verso il paesaggio risulta così analogo alla sorpresa che prova il protagonista de La primavera del fiore di pesco quando esce dalla grotta e trova il villaggio. L’edificio è costituito da tre volumi vetrati, collegati fra loro da giardini e da un percorso che termina in una terrazza in legno con vista sullo stagno,il cui pavimento è attraversato dai tronchi della vegetazione.

Nella progettazione degli spazi aperti l’intento dei progettisti è quello di permettere ai visitatori di sperimentare il rapporto con la natura in modo diversificato, ma sempre intenso, attraverso una serie di giardini giapponesi karesansui. Una tipologia di giardino caratterizzata dall’assenza dell’acqua, uno dei quattro elementi base del giardino giapponese insieme alle rocce, alla crescita delle piante e agli elementi del paesaggio, e dove i sassi, la ghiaia e la sabbia sono utilizzati a rappresentare l’acqua stessa.

I tre giardini, Chuan, Yuan e Qi sono progettati secondo la forma e lo spazio di ogni cortile. Chuanè composto da due pietre, che sono in realtà un’unica pietra tagliata a metà, che interpreta la pioggia ed è utilizzato come panchina. Yuan è un’ulteriore transizione da esterno a interno e prende il suo significato dal drago nascosto del Libro dei Mutamenti o I Ching. È fatto di ghiaia color canapa scura, che simboleggia l’acqua: sei pietre sono combinate in gruppi di tre, due e una per mostrare i draghi che emergono dall’acqua. Qui la trama della parete in terra battuta sullo sfondo suggerisce l’arrivo delle nuvole. Qi, il giardino attorno al quale sorgono i tre volumi principali, mostra il punto di inizio della fitta foresta naturale che scorre fra le mura dell’edificio. Secondo lo Shan HaiJing – o Libro dei monti e dei mari, una descrizione geografica e culturale della Cina, in parte favolistica e mitologica, risalente a più di 2.000 anni fa – ci sono cinque montagne fatate nella parte orientale del mare di Bohai: Daiyu, Yuanjiao, Fanghu, Yingzhou e Penglai. Nel giardino Qi cinque isole indipendenti simboleggiano le cinque montagne fatate, e il verde che emerge dal muro è come una fonte, fatta dalle piccole gocce d’acqua che si diffondono.

I volumi del padiglione sono in vetro e per realizzarli sono state utilizzate lastre di grandi dimensioni – 3×5 metri – così da ridurre al minimo le interruzioni alla vista e annullare la separazione fra il paesaggio e gli spazi interni. I tetti sono a falda. Molto interessanti i materiali utilizzati per le pareti che circoscrivono gli spazi esterni e funzionano da seconda quinta: terra battuta e scisto, una pietra grigio bluastra. La terra per le murature è stata ricavata dagli scavi del cantiere. Fortunatamente il suolo del sito è composto di strati che vanno dall’ocra, al rosso al bruno e che i progettisti hanno definito “la terra di cinque colori”. Gli strati, compattati secondo una tecnica tradizionale rivisitata con tecnologie moderne, danno vita a murature dalle texture cangianti e molto vibranti, che cambiano colore con la pioggia. Oltre alla terra sono stati impiegati materiali locali per il progetto, come tributo alla tradizione del villaggio: la pietra, alcune travi di legno antico e il bronzo. Mentre nella sala esposizioni al piano terreno sono esposte antiche reliquie delle dinastie Ming e Qing, raccolte nei villaggi vicini.

Alcune scelte del progetto, come la preziosità delle texture delle pareti e l’utilizzo di murature quali quinte di fronte alle vetrate, non possono non ricordare al lettore occidentale il Padiglione per l’Esposizione Universale di Barcellona del 1929 di Ludwig Mies van der Rohe, dove, per chiudere il cerchio fra oriente e occidente, la Fundaciò Mies van der Rohe ha incaricato nel 2018 l’artista statunitense Spencer Finch di realizzare un’installazione fatta di quindici pietre, così da ridurre le distanze fra un’architettura simbolo del Movimento Moderno e il celeberrimo giardino secco del tempio di Ryoan-ji, a Kyoto.