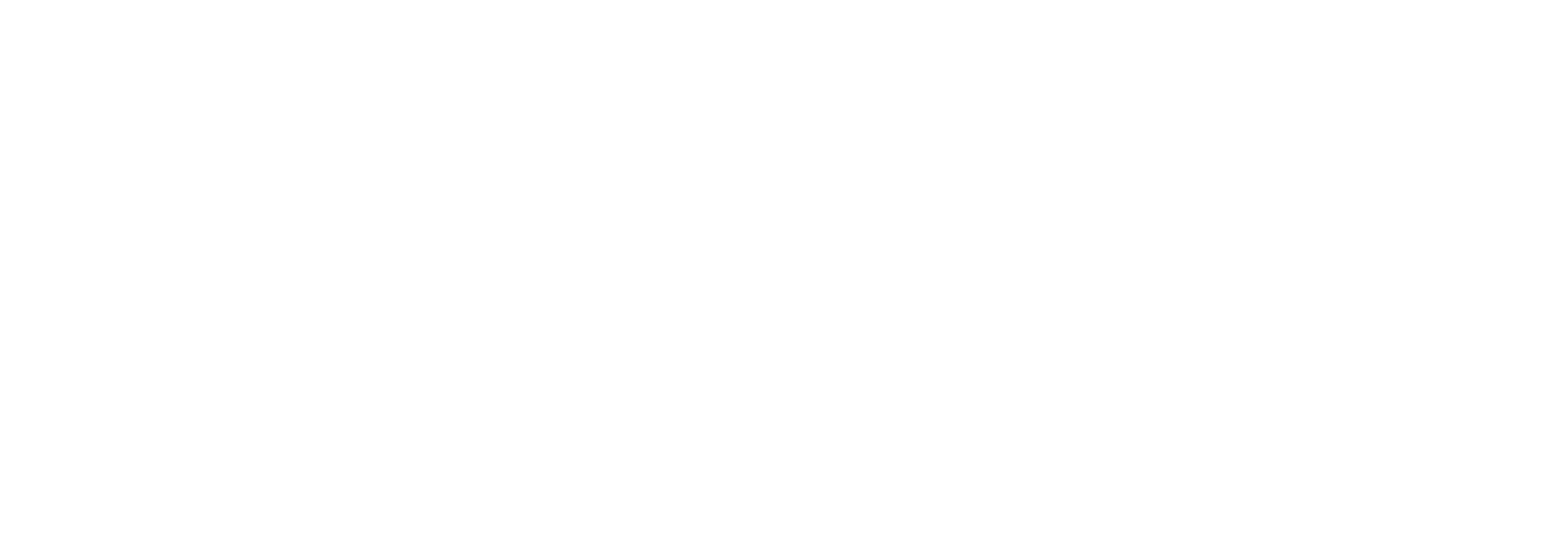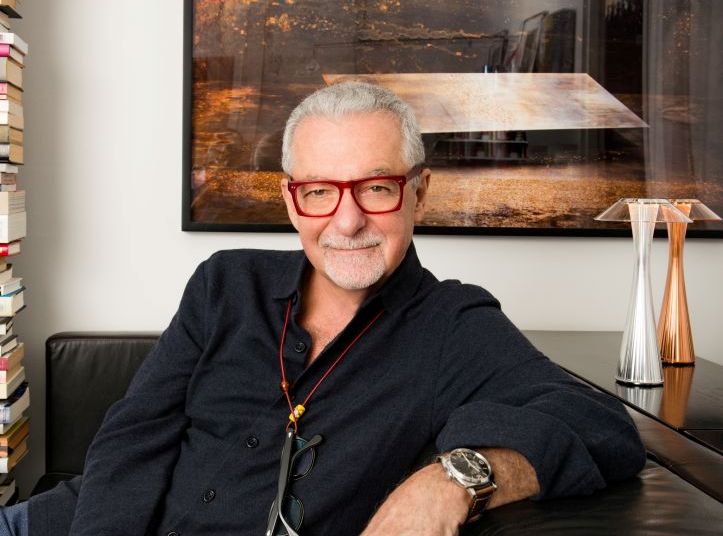Autenticità, originalità, emozione. Racchiuse in progetti d’interni in cui l’ospite è sempre il protagonista indiscusso. All’insegna di uno stile a misura della sua personalità. La nostra intervista ad Adam D. Tihany, una delle più iconiche firme dell’hospitality design contemporaneo
Adam D. Tihany è un personaggio fuori dal comune. Con una storia decisamente interessante. E un percorso professionale in linea con la sua originale creatività. Natali in Transilvania, infanzia in Israele, una laurea al Politecnico di Milano negli anni eroici dell’industrial design italiano. Poi, intorno alla metà degli anni ’70, il trasferimento a New York, che segna l’inizio di una brillante carriera destinata a spaziare nei decenni successivi in ogni ambito dell’hospitality design, dalla progettazione d’interni per hotel e ristoranti fino ad arrivare, in anni recenti, a quella delle grandi navi da crociera. La nostra conversazione è un affascinante viaggio nel tempo, ma soprattutto il racconto di un incontro fra due mentalità, quella europea e quella americana, che nel lavoro di Tihany hanno trovato una straordinaria sintesi.

Ti sei formato al Politecnico di Milano alla fine degli anni ’60, un’epoca di grande fioritura per il design italiano: questo quanto ha influenzato la tua carriera?
Più che influenzarla, è stato decisivo. Considero la mia matrice culturale profondamente italiana sotto ogni aspetto. La mia formazione giovanile, del resto, è coincisa con la nascita dell’industrial design contemporaneo, e il Politecnico di Milano ne è stata la culla a cavallo tra gli anni ’60 e ’70 grazie all’influenza dei grandi maestri che vi hanno insegnato in quel periodo. La proiezione internazionale di questo formidabile fenomeno culturale è stata poi uno dei fattori che mi hanno portato a trasferirmi a New York, un altro contesto di eccezionale vitalità creativa. Ma come spesso succede nella vita, a dare una spinta decisiva alla mia carriera di designer è stato un incontro del tutto casuale.
Come è accaduto?
Da giovane architetto di formazione europea ero abituato a una visione d’insieme del mio lavoro, a considerarmi un problem solver in grado di gestire tutti gli aspetti di un progetto, mentre la mentalità americana già allora era molto orientata alla specializzazione. Allo stesso tempo, la mia formazione italiana faceva di me un interlocutore perfetto per chi dall’Europa volesse avviare delle iniziative di business negli Stati Uniti. Ero una sorta di anello di congiunzione, in grado di capire entrambe le mentalità e farle dialogare tra loro. E proprio in uno dei tanti incontri che si facevano nella vivace New York dell’epoca mi fu proposto di curare l’interior design della prima sede americana dello storico ristorante La Coupole di Parigi. Un esordio piuttosto impegnativo per chi come me all’epoca non sapeva nulla di ristorazione, ma che è stato un enorme successo fin dal giorno della sua inaugurazione, nell’inverno del 1981. L’ho progettato, diciamo così, all’europea, occupandomi di tutto, dall’interior design all’illuminazione, dalle decorazioni alle divise del personale fino alla mise en place. Praticamente senza saperlo avevo non solo trovato la mia dimensione come progettista ma creato una nuova figura professionale, il restaurant designer. Tutto è nato da qui, e il resto è storia.

La tua carriera copre un arco di tempo molto lungo. Cos’è cambiato in questi anni?
Il design è diventato un fenomeno popolare! E gli spazi dell’ospitalità, che sono per natura aperti, accessibili, e come si dice oggi emozionali, hanno avuto un ruolo importantissimo nell’avvicinare le persone all’esperienza che un bel progetto d’interni può offrire. Attraverso il linguaggio dell’interior design le persone possono immaginare, sognare, provare sensazioni nuove, immergersi in atmosfere sconosciute, senza dover nemmeno viaggiare. Il design è un’esperienza aperta a tutti, è un immaginario creativo straordinario a portata di mano. Non è sorprendente che sia sempre più popolare nell’hospitality.
Nel creare queste esperienze cosa ti ispira di più?
Innanzitutto l’autenticità. Capire e rispettare il luogo, il suo spirito e la sua storia è la prima “bussola creativa”. Il modello dell’hotel come home away from home fa parte del passato, oggi il viaggio inizia già nell’immaginario delle persone, che spesso sanno tutto della loro destinazione ancor prima di partire e quindi si aspettano esperienze autentiche, originali, fedeli allo spirito dei luoghi. Autenticità ovviamente significa anche farsi ispirare senza però cadere in rappresentazioni stereotipate. E’ un equilibrio a volte facile da cogliere, a volte più complesso, ma comunque indispensabile.

Qual è per te lo spazio più importante in un progetto d’interni?
Quello in cui le persone si fanno fotografare. O come si dice oggi, quello più “instagrammabile”. Quello che in qualche modo rappresenta il DNA del progetto e l’atmosfera che ha saputo creare. Il problema è che è molto difficile identificarlo e progettarlo a priori. Quasi sempre è l’ospite a sceglierlo, e non necessariamente coincide con quanto aveva in mente il designer. E’ una lezione che ho imparato negli anni in cui, oltre che progettista, sono stato anche proprietario di un ristorante. Infatti, quando mi chiedono quale sia il tavolo migliore di un locale, rispondo sempre “quello dove vorrebbe sedersi Frank Sinatra”. Una battuta, certo, ma che rende bene l’idea che il giudice definitivo del tuo lavoro, alla fine, è sempre l’ospite.
C’è un elemento di riconoscibilità nei tuoi progetti?
Sono molto orgoglioso di rispondere di no. Ognuno ha la sua vocazione, intendiamoci, molti interior designer sono diventati con pieno merito dei veri e propri brand e non c’è nulla di sbagliato. Personalmente ho sempre preferito un approccio più “sartoriale”, cercare di capire cosa desidera e si aspetta il mio interlocutore e creare una soluzione per lui, non per me stesso. Del resto credo siano proprio l’energia creativa che nasce da ogni progetto, gli stimoli che ogni volta ti spingono a fare qualcosa di diverso, il motivo per cui ho fatto e continuo dopo tanti anni a fare questo mestiere.

Hai firmato molti progetti nell’ambito hospitality e, in questi ultimi anni, anche nel settore delle navi da crociera. Cos’è per te il lusso?
Non c’è niente di più personale e individuale, di più legato a chi siamo, alle nostre radici, alla vita che facciamo. Non esiste una definizione valida per tutti. Per un newyorkese d’adozione come me il lusso è spazio e tempo, è un venerdì pomeriggio di sole, seduto su una panchina di Place des Vosges a Parigi a fumare un sigaro. Comunque, qualcosa di non legato al valore materiale delle cose. Piuttosto, uno state of mind. Cogliere quello di chi si rivolge a me per un progetto, interpretarlo e dargli forma è la vera sfida.
Abbiamo parlato di navi da crociera, un ambito per te particolarmente importante in questi ultimi anni. Che vincoli e opportunità propone qui l’interior design?
Parliamo sempre di spazi per l’ospitalità, quindi le funzioni sono sostanzialmente le stesse. A cambiare sono le dimensioni e le geometrie degli spazi, che impongono una serie di limiti dovuti ai criteri della progettazione navale. Ma dal mio punto di vista, il tema progettuale più importante è il fatto che gli ospiti si trovano in un ambiente che li tiene in qualche modo “prigionieri”. Il che impone di creare quanti più punti di interesse, ricreazione e svago possibili per rendere il loro soggiorno piacevole e ogni giorno sorprendente. In contesti di questo tipo la multifunzionalità e convertibilità degli spazi è un tema chiave, perché permette di creare atmosfere ed esperienze sempre nuove pur rimanendo entro limiti molto rigidi. E tutto questo va pianificato in fase di progetto, sin nei minimi dettagli.

Chiudiamo con uno sguardo al futuro: che hospitality design possiamo aspettarci da qui ai prossimi dieci anni?
Non so se sia più una previsione o un auspicio, ma credo che la dimensione comunitaria e socializzante degli spazi dell’ospitalità sarà uno dei leitmotiv dei prossimi anni. Internet, i social media, le nuove tecnologie sono qualcosa di fantastico, ma rischiano di estraniare le persone. In parte già lo vediamo. Io credo invece che i nostri cinque sensi siano qualcosa di insostituibile, una parte profonda della nostra natura, e che il recupero di questa dimensione relazionale, sociale e comunitaria sia uno dei compiti del design che verrà.